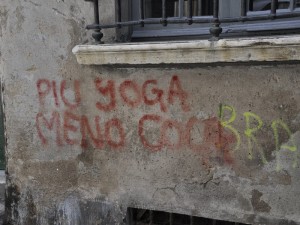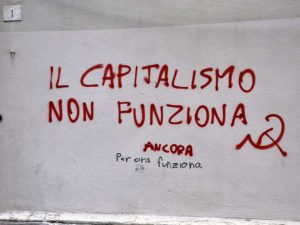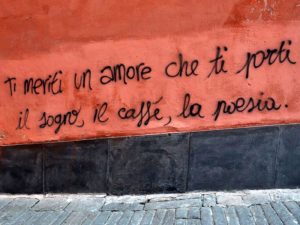Il cedro del Libano (Cedrus libani) è una pianta elegante e maestosa. Così regale che i suoi rami non sono semplici rami, ma si chiamano palchi, perchè si aprono ampi, quasi paralleli al terreno. Le sue pigne, ovvero i coni, sono gioielli verdi finemente cesellati.
Assai ricercato per parchi e giardini, soffre in città come tanti altri alberi urbani, non solo aria mefitica, ma anche mutilazioni e capitozzature. Mi accade a volte di osservarne con qualche preoccupazione dignitosi esemplari maltrattati e negletti, costretti in uno spazio troppo angusto per mostrare la loro forma.
Non questo cedro, che si erge agile e sontuoso di fronte a un’altrettanto sontuosa villa di nobili origini. Villa Scassi è conosciuta a Genova come ‘l’ospedale di Sampierdarena’, ma la sua storia meriterebbe più attenzione e interesse, perchè in realtà la villa con l’ospedale non c’entra granchè ed in comune hanno quasi soltanto il nome e l’ubicazione. La villa, detta più precisamente Imperiale Scassi, sorge nella zona centrale del quartiere, lungo l’asse viario che dalla Lanterna conduceva verso la Val Polcevera e il Ponente e lungo il quale, nel XVI secolo, sorse un imponente complesso di ville, oggi immiserito e degradato, ma ancora riconoscibile. Edificata nel 1560 da Vincenzo Imperiale, venne acquistata nel 1800 dall’illustre medico e studioso Onofrio Scassi e dei suoi due proprietari ha mantenuto il nome. Fu progettata da discepoli o emuli del grande architetto Galeazzo Alessi, con alle spalle un vasto giardino digradante, un parco rinascimentale disegnato per farle da corona e areola. La ristrutturazione della città ha spezzato l’incanto, da quando negli anni ’30 del secolo scorso, il giardino e la villa sono divisi da una rumorosa e ingombrante arteria cittadina, via Antonio Cantore. Nel frattempo la villa veniva sempre più soffocata in mezzo all’edilizia residenziale di un quartiere in disordinata espansione e alla sommità del giardino, fu costruito l’ospedale che dalla villa oggi prende il nome. Ma il parco è rimasto ed è sollievo per chi ascenda o scenda da qualche padiglione, ambulatorio o day hospital, due passi in mezzo all’eleganza di un verde antico, che accusa il degrado, ma a testa alta.
Sampierdarena è un quartiere di contrasti, dall’apparenza squallido e anche un po’ sudicio, percorso da fermenti opachi. Ma fra le vie incolori nasconde angoli particolari, incontri, tesori e storie. Oggi la villa presenta la sua facciata posteriore alla rumorosa strada principale, mentre il prospetto anteriore si trova in una via minore, più vicina al cuore antico di Sampierdarena, via Nicolò D’Aste. Provenendo per questa via da ponente, attraverso carugi angusti, la villa appare alta e bianca, pulita. E da questa parte, da dove il parco non si immagina neppure, il cedro, solo, è il suo albero custode, ornamento e sostegno della sua storia e della sua eleganza.
Onore ai cedri del Libano e al loro immutabile fascino. Guardandone dal basso gli stupendi palchi, si vorrebbe essere un uccelletto qualsiasi per potersi accovacciare un po’ su quelle solide fronde.
cliccando sulle immagine, le fotografie in formato 800×600 px si aprono in un’altra pagina