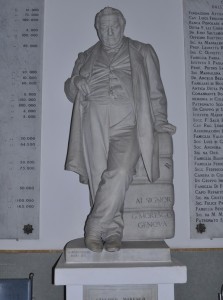Non so come questo modesto e dignitoso alberello di melograno sia arrivato in un posto tanto bizzarro, così inusuale per un nobile albero da giardino e frutteto, il terrapieno erboso fra la strada e l’arido edificio di un centro commerciale di periferia, che ospita fra gli altri un supermercato Coop. Che sia stato il caso, il vento o qualche altra forma di inseminazione naturale mi sembra improbabile. Allora qualcuno ce l’ha messo? E perchè? Forse per le lucide foglie verdi e i fiori che, come è poeticamente noto, sono vermigli? Stupendi i fiori del melograno, magici i suoi frutti. Ho già detto di questo nel vecchio blog (23 giugno 2009) e in un post più recente (31 dicembre 2011).
Per volere, o destino, o fortuna, cresce un melograno vicino alla Coop di Molassana (Lungo Bisagno Dalmazia, Genova). Dentro al supermercato sono in vendita i frutti ipertrofici di un suo qualche fratello, molto gonfi e molto rossi, che ho scoperto essere cileni. Sono stata in Cile, amo i cileni e la loro agricoltura, ma è un po’ triste e stupido che i melograni debbano fare mezzo giro del mondo per essere mangiati. Dentro al supermercato sono in vendita anche varie marche di succo di melograno, le cui virtù salutari sono rinomate per combattere il logorio del progresso che ci ossida l’esistenza.
Qui fuori, sulla sponda dell’asfalto, questi frutti probabilmente non hanno un buon sapore. Il melograno ornamentale ha frutti secchi ed acidi e questo per di più, anche se ornamentale non è, cresce sul ciglio di una strada a grande percorrenza, fra i vapori dei carburanti e i miasmi degli scappamenti. Non fa venire voglia di assaggiarlo.
A primavera ce l’ha certo messa tutta a fiorire, e, ornato delle sue carnose campane rosso fuoco, sarà stato, non ho dubbi, magnifico. Non so perchè, ma mi stringe il cuore pensare, che, nella fretta fra il parcheggio e la spesa, davvero in pochi lo avranno notato. D’altra parte è assai raro che la gente, in città, guardi gli alberi. Ben diversa la sua sorte sarebbe stata se invece che dietro le sbarre di un centro commerciale fosse cresciuto in un frutteto o in un elegante giardino, potato, concimato e riverito. In realtà non c’è di che stupirsi, il melograno è un albero di poche pretese, che cresce bene anche su terreni poveri e, in posizione soleggiata e al riparo da forti gelate, non conosce avversità. Guerriero di antiche origini e dalla storia millenaria, pronto ad adattarsi persino fra catrame e petrolio.