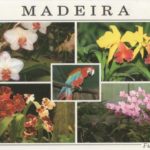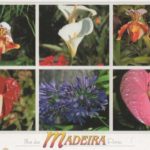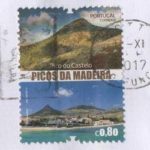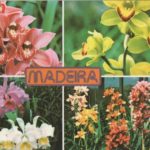A capo dei filari nelle antiche vigne di Camillo Benso, a Grinzane Cavour, sbocciano le rose. Non sono messe a caso, e non per la loro bellezza. Si dice che le rose servano da indicatori del morbo bianco, lo oidio, e la loro contaminazione precede di un poco quella delle viti, fornendo un vantaggio al viticoltore accorto per prendere per tempo le misure adeguate a salvare la sua preziosa piantagione.
A capo dei filari nelle antiche vigne di Camillo Benso, a Grinzane Cavour, sbocciano le rose. Non sono messe a caso, e non per la loro bellezza. Si dice che le rose servano da indicatori del morbo bianco, lo oidio, e la loro contaminazione precede di un poco quella delle viti, fornendo un vantaggio al viticoltore accorto per prendere per tempo le misure adeguate a salvare la sua preziosa piantagione.

Vitis vinifera – Grinzane Cavour (CN)
Le viti vengono accuratamente potate con il metodo Guyot che lascia sulla pianta un tralcio corto con due gemme – lo sperone – che darà origine al capo a frutto dell’anno successivo, e un tralcio più lungo, di un anno – il capo a frutto – che porta un certo numero di gemme ibernanti.

Trifolium incarnatum
Fumaria officinalis
Fra i filari cresce erba rigogliosa e vari fiori colorati, trifogli dai lunghi capolini cilindrici rosso vivo (Trifolium incarnatum), contorte fumarie dai microscopici fiori di intenso color rosa (Fumaria officinalis) e strani fiori viola. Strani perché non li ho mai visti e scopro che sono effettivamente una specie neofita di origine americana, e anche se probabilmente sono qui già da un certo tempo, sono ancora classificati come alloctona casuale. E’ la facelia a foglie di tanaceto (Phacelia tanacetifolia) con i suoi bei gruppi di fiori brillanti disposti in una singolare infiorescenza a spirale detta scorpioide. Proprio dalla forma dell’infiorescenza, a fascio o mazzo, deriva il suo nome, mentre le foglie, profondamente incise e seghettate ricordano veramente quelle del Tanacetum vulgare (vedi 24 luglio 2008), da cui l’epiteto specifico.

Phacelia tanacetifolia
Infiorescenza scorpioide
Benefica intrusa, la facelia è ricca di polline e nettare che attira le api e altri insetti ed è perciò un’eccellente mellifera. Ricca di sostanze azotate, è ottima anche per il sovescio, una pratica che serve per rinvigorire i terreni impoveriti, specie in presenza di monocolture, come è appunto quella della vite.

Phacelia tanacetifolia
Inoltre la facelia è una pianta egoista e dove cresce rilascia nel terreno sostanze chimiche che impediscono la crescita di altre specie vegetali. Diventa così una specie di diserbante naturale, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono.
A causa delle sue proprietà questa pianta viene frequentemente coltivata e non è facile prevedere se questa scelta si rivelerà vincente anche nel lungo periodo, tuttavia per adesso sembra gradita e felice.